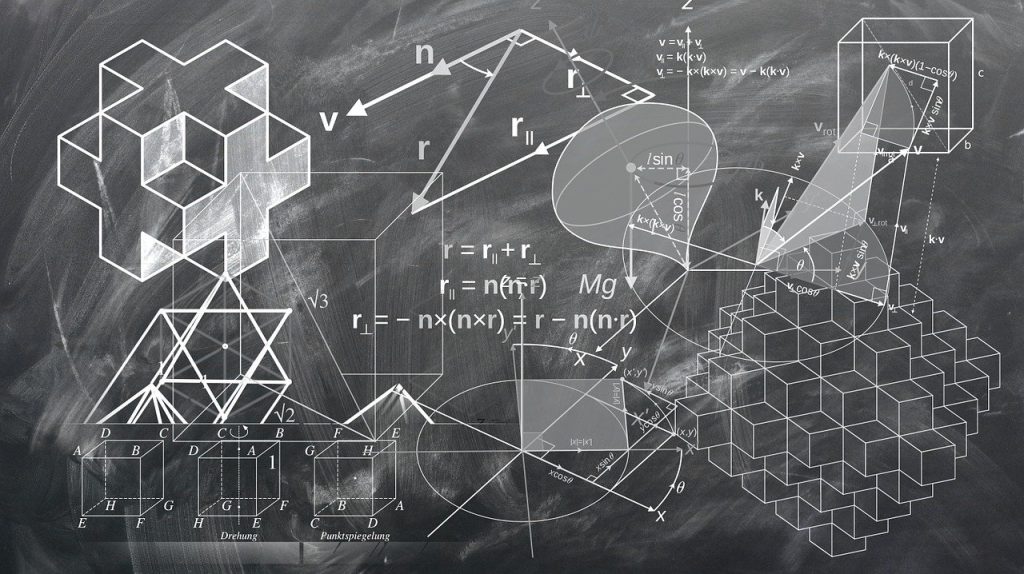
Da I racconti del tempo che non sarà più
di Simona Maria Frigerio (tutti i diritti riservati, vietata la riproduzione anche parziale)
L’anno di ‘grazia’ 1978 principiò con le candele magiche. Da una di quelle stelline argentee scappò, però, una scintilla che finì dritta sulla tendina sintetica infiammandola. Il nonno corse alla brocca dell’acqua, sempre al centro della tavola, e la rovesciò per intero inzuppando se stesso e allagando mezzo soggiorno. Il tessuto, quasi fosse un essere vivente, offeso dal gesto, prese a contorcersi come un verme grigio appeso all’amo e, al centro della corolla di un enorme fiore rosa e giallo, che adornava il tessuto dozzinale, si aprì la bocca di un cratere. Scoppiammo tutti a ridere, un po’ per l’imbarazzo (il nonno con il gambo della candela magica ancora penzolante in una mano) e un po’ per il sollievo – quasi ci fossimo salvati da un incendio o, più appropriatamente, guardando i nostri piedi bagnati, da un’inondazione. La tendina sarebbe rimasta al suo posto a monito collettivo e futura memoria. Nessuno pensò mai di sostituirla anche perché avrebbe significato comperarne ben quattro visto che il soggiorno aveva due finestre. La nonna slegò il cordone bianco, arricciò il tessuto un po’ di più e, sebbene il risultato fosse asimmetrico – con una tenda che sembrava (ed era) più lunga dell’altra – accogliemmo il 1978 con un autentico sospiro di sollievo.
Da lì a qualche giorno sarei tornata a scuola, a quella maestra che detestavo e che mi detestava. Friulana, come i nostri vicini P., con la medesima puzza sotto il naso e quell’aria severa da austro-ungarica. Ricordo che aveva zigomi imponenti, come un imperatore e, del resto, chiamandosi Magiar mi rammentava sempre storie di battaglie con, in sottofondo, la Marcia di Radetzky (musica e teatro erano le passioni di famiglia). Tra noi c’era una trincea nella quale seppellivamo i corpi delle nostre vittime. Lei mi odiava perché io ero stata la prediletta della passata insegnante, la prima della classe suo malgrado ma, proprio per questo, la più invidiata. Io la odiavo perché lei cercava di favorire relazioni diplomatiche tra me e S. (sempre lui: l’S. del mio cortile), il quale, a sua volta, cercava di sabotarmi spalleggiato da B. (con il suo apparecchio ai denti e il volto prematuramente deturpato dall’acne) e P. (che sembrava un eunuco a forma di mongolfiera). Non poteva esserci pace in quella classe – come non c’era tra i vari sudditi nell’Impero Asburgico…
Durante quell’anno la cosa che ci colpì di più, a livello scolastico, fu l’arrivo in tivù di Fonzie – e non intendo la patatina fritta. Ci innamorammo tutti e tutte di quel suo giubbotto di pelle nera che non sapevamo fosse ormai fuori moda e che, imparai giusto qualche anno più tardi, stava molto meglio su James Dean o Marlon Brando. Gli States entravano nelle case degli italiani riportando in auge la moda e le inibizioni degli anni 50 e 60 in una Milwaukee che non assomigliava nemmeno lontanamente alla maggiore città sul Lago Michigan, dopo Chicago. A fine anno, al contrario, sarebbe cominciato a circolare anche nelle scuole il film che fece disinnamorare tutte e tutti della campagna: L’albero degli zoccoli. Costretti su sedie di tubolare e legno, dure e scomode, in auditorium improvvisati – dove gli alunni ondivagavano come la marea, da destra a sinistra, cercando di posizionarsi tra le due teste dei compagni della fila di fronte per riuscire a vedere qualcosa su schermi ancora più improvvisati (che, spesso, erano semplici lenzuola), soffrivamo – come il maiale squartato – per 175 minuti in attesa della fine. Aldilà del dialetto incomprensibile per tre quarti della classe, quell’urlo d’animale mentre viene sgozzato ce lo sognammo per mesi: allora quei film erano considerati educativi (la loro peggiore pecca era che fossero tanto noiosi) e di certo nessuno si faceva problemi ad ammazzare un maiale (o un’aragosta) di fronte a una telecamera. Tempi in cui l’ipocrisia ambientalista non era ancora entrata al cinema: in fondo, ciò che si fa in un macello perché non si dovrebbe fare su un set?
In pratica la mia vita di bambina iniziava troppo presto, quando era inutile alzare la tapparella perché fuori era ancora buio. Mi lavavo come i cani (perché i gatti si lavano, eccome!, avrei imparato più tardi), ossia pochissimo – evitando soprattutto di ‘sciuparmi’ i denti con lo spazzolino o i capelli con il pettine. Poi mi tuffavo nella nebbia rimpiangendo le coperte ancora calde per arrivare, mezza addormentata, in una scuola piena di spifferi a causa dei finestroni dagli infissi arrugginiti e cigolanti, dalle mura slavate e sberciate dal tempo. I compiti a casa erano la punizione pomeridiana: quando erano temi (che avrei dovuto poi copiare in bella calligrafia) andava bene; ma quando dovevo imparare a memoria i versi di qualche poesia di cui non capivo nemmeno il senso – Il 5 maggio fu un vero incubo, non parliamo della Cavalla storna che mi sfuggiva fin dal titolo… – oppure la sfilza di monti, mari e fiumi che sembrava affollassero ogni centimetro quadrato d’Italia, andava molto peggio. Hai voglia inventarsi filastrocche per mandarli a mente: chi non ricorda Ma con gran pena le reca giù? Che corrispondeva a Marittime, Cozie, Graie, Pennine Lepontine, Retiche, Carnie, Giulie… Solamente tanti ma tanti anni dopo avrei imparato ad amare la geografia con il mio professore di geografia regionale all’università – che univa letteratura e paesaggio, trasportandomi in un universo di emozioni – e tanti altri anni dopo ancora, quando avrei cominciato a girare il mondo e a vederle le Carnie e le Giulie, e poi a spingermi sempre più lontano fino agli Urali e ancora oltre. Finalmente alle cinque in punto iniziava la Tivù dei ragazzi e allora potevo dedicarmi alla mia vera passione: sciropparmi immagini e canzoni e battute e balletti e film e tutto quello che passava sul piccolo scherno fino a che la Rai dava la buonanotte e io dovevo arrendermi ad andare a letto – senza aver mai sonno. Il sonno, ce l’avevo il mattino.
I miei preferiti in quegli anni erano Cochi e Renato – Il buono e il cattivo, Il poeta e il contadino, eccetera. Altro che Singing in the Rain, la mia preferita era E la vita, la vita. In quel ʻ78 erano un po’ di anni che la cantavo – stonata come non mai – a squarciagola, ogni volta che dovevo affrontare il tempo mefitico milanese per andare a scuola: “E, la vita la vita / e la vita l’è bella, l’è bella / basta avere l’ombrella, l’ombrella / ti ripara la testa, / sembra un giorno di festa. / E, la vita la vita / e la vita l’è strana, l’è strana / basta una persona, persona / che si monta la testa, / è finita la festa”. Ma quel 28 gennaio, a Sanremo, avrei cominciato ad adorare anche un altro mezzo matto come me, era Rino Gaetano e la canzone era Gianna. Mia madre, ricordo, che mi proibiva di cantarla ma a me quel ‘tartufo’ piaceva e, dato che lei per fortuna non c’era mai – tranne quando veniva a trovarci a cena – potevo sbizzarrirmi, cantando e ballando: “Gianna aveva un fiuto eccezionale, per il tartufo / Ma la notte la festa è finita, evviva la vita / La gente si sveste e comincia un mondo / un mondo diverso, ma fatto di sesso / e chi vivrà vedrà…”.
Fu un magnifico inverno canterino, ma il clou delle mie giornate era un altro: l’ora dell’intervallo, l’ora delle acerrime battaglie per conquistare le figurine dei nostri album. Ci regalavano sempre questi album, ma poi i grandi non prevedevano che dovessimo riempirli e, quindi, bisognava sviluppare la ‘tecnica’. Si dovevano posizionare due figurine una sopra l’altra, cercando di renderle leggermente bombate perché sbattendo le mani si riuscisse a capovolgerle. Ero un vero fisico nucleare con le figurine: sapevo calibrare al meglio i pesi, spostavo leggermente quella soprastante, calcolavo la distanza delle mani, sapevo come picchiare i palmi uno contro l’altro in maniera tale che l’aria si propagasse in senso orizzontale (e non si disperdesse in verticale) per ottenere il massimo dall’onda d’urto. A volte riuscivo persino a girarne tre: una mia contro due dell’avversario. Collezionai un sacco di album, tutti bellissimi, anche di disegni animati (allora non sapevamo ancora si chiamassero anime: le anime erano solo quelle dei morti che stavano nelle immaginette sul comodino il 2 Novembre). Anime che magari nemmeno seguivo, come Capitan Harlock, che sarebbe atterrato sui nostri teleschermi l’anno successivo e di cui non avrei guardato manco una puntata ma del quale mi piacevano tantissimo le donne dai capelli lunghissimi – come li avrei voluti io se non avessi avuto una madre che, le poche volte che la vedevo, mi portava dal parrucchiere a farmi rapare quasi fossimo ancora in guerra e temesse che mi riempissi di ‘pane e pettini’ (ossia di pidocchi).
Eh sì, quel gennaio iniziò proprio alla grande. Non sapevamo ancora che sarebbe stato l’anno in cui la mia generazione avrebbe perso la propria innocenza.
To be continued…
I capitoli precedenti per chi se li fosse persi:
venerdì, 27 maggio 2022
In copertina: Foto di Gerd Altmann da Pixabay.







