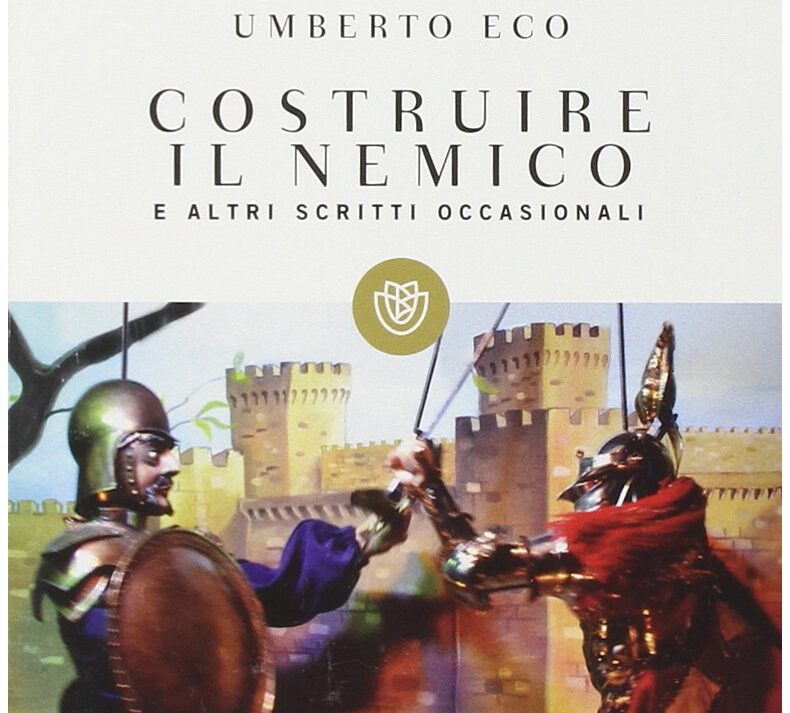
Il gruppo 63: molto rumore per nulla
di Simona Maria Frigerio
Per una volta non recensiremo propriamente un libro, quanto alcune pagine dello zibaldone Costruire il nemico. E altri scritti occasionali di Umberto Eco (che contiene, altrimenti, due saggi di capitale importanza, quello che dà il titolo alla raccolta e Veline e silenzio).
Lo faremo partendo proprio dalle critiche al Gruppo 63, di cui Eco fu tra gli ideatori, sostenitori, partigiano e, forse, un po’ nostalgico narratore anche nello zibaldone. Perché quella neo-avanguardia letteraria, ci spiace ammetterlo, non produsse molte opere e ancor meno autori che abbiano lasciato il segno (a parte rari che, in ogni caso, non devono certamente alle sperimentazioni sull’illeggibilità o al potere massmediatico di atteggiarsi a giovani ‘turchi’ il loro successo posteriore).
Di quel Gruppo però Eco ha ereditato molte, forse troppe velleità letterarie, quando il suo principale merito (a parte essere stato tra i massimi semiologi europei) è stato di aver esercitato con lucida ironia il difficile mestiere della critica e aver scritto in maniera quasi enciclopedica su qualsiasi argomento.
E qui vogliamo soffermarci proprio su uno degli stilemi di Eco, che quest’ultimo attribuisce (giustamente) anche a Hugo ma che noi abbiamo ravvisato, ad esempio, nello Zola di Le ventre de Paris, dove i mercati generali, Les Halles, sono ritratti con un’abbondanza di elenchi alimentari da fare invidia ai succitati: “Tutt’intorno i formaggi puzzavano” (si veda anche il saggio di Eco in tema, intitolato Delizie fermentate) e più oltre: “dei piccoli caci uno accanto all’altro, dei Gournay schierati e piatti come medaglie, formavano una coltre più scura, chiazzata di sfumature verdastre. […] Lì, accanto ai panetti di burro da una libbra, troneggiava in mezzo alle foglie di bietola, un Cantal gigante, come tagliato a colpi d’ascia; appresso venivano un Chester dorato, un Groviera, simile a una ruota caduta da un carro di barbari; dei formaggi olandesi, tondi come teste mozze imbrattate di sangue raggrumato […]. Un Parmigiano, in mezzo a quella pesantezza di pasta cotta, aggiungeva un pizzico di fragranza aromatica. Tre forme di Brie, poste su tavolette rotonde, erano malinconiche come una luce pallida…”. E così potremmo continuare ma, visto che, a differenza di Henry Fielding, con il suo The History of Tom Jones, a Foundling, non siamo pagati a parola, qui chiudiamo e torniamo a Eco, perché il nostro non disdegna anzi ricalca pedissequamente il maestro dell’elencazione, giustificando tale tortura per il povero lettore, in primis con la possibilità per il lettore di non leggere intere pagine di un libro (ma, a questo punto, uno si chiede perché scriverle?) e, in secondo luogo, con l’idea che l’elenco sia “un’ipotiposi che fa vedere per eccesso di flatus vocis” che, tradotto per i comuni mortali, significa una “rappresentazione vigorosa che mostra per eccesso di parole senza interesse”. In pratica, l’elenco ci immergerebbe come un mantra laddove la ragione si nega.
E però se già l’elenco annoiava ai tempi di Hugo. E Proust riusciva, al contrario, a ricreare rappresentazioni vigorose di balli e inviti salottieri (quanto Visconti in Il Gattopardo), senza l’uso di elenchi; ai tempi di Eco è semplicemente ingiustificabile.
Ricordo ancora quando, in aereo, un mio vicino di sedile vedendo che stavo leggendo Il pendolo di Foucault, mi chiese (ma, in realtà, affermò): «Non leggerà mica tutte, tutte le pagine, vero?». Ne rimasi offesa: come disdegnare un rigo o sorvolare un paragrafo? Irrispettoso per l’autore, ma anche potenzialmente fuorviante per il lettore: se così facendo avessi perso un passaggio importante per comprendere un libro che, a conti fatti, era un elefantiaco rifacimento di Traumnovelle (Doppio sogno) di Arthur Schnitzler in salsa ‘ermetica’ (invece che erotico-patinata, quale fu la trasposizione di Stanley Kubrick con Eyes wide shut)? Della serie: less is more.
Ed è proprio in alcuni dei suoi saggi, scritti per occasioni fondamentalmente mondane come sono i Convegni – dove il pubblico latita, gli studenti se cooptati sonnecchiano, e una ristretta cerchia di cosiddetti intellettuali si compiace della propria ‘sapienza’ (o insipienza?) – che Eco usa l’elenco probabilmente per risolvere un problema esistenziale: come riuscire a essere contemporaneamente semiologo, filosofo, scrittore (anche di romanzi), traduttore, bibliofilo, medievista, saggista e intellettuale e avere anche il tempo per comporre relazioni più o meno gradevoli, molto colte ma soprattutto della durata giusta per un intervento, scrivendole velocemente?
Ci pare questa la risposta del perché Eco non disdegni di imitare Hugo in Andare per tesori, dove elenca tutte le reliquie che esistono in Italia e in Europa, a volte (ovviamente) anche presenti in luoghi diversi sebbene attribuite al medesimo santo (o santa). Nel succitato Delizie fermentate, per ricordare Piero Camporesi, non solamente attinge a piene mani nella passione di quest’ultimo per il catalogo, ma vi aggiunge di suo indugiando su “formaggio di fossa, reblochon, roquefort o vacherin” (con il gusto del gourmet e del poliglotta mischiati indelebilmente insieme). E in Astronomie immaginarie, sembra quasi di vederlo affondare le mani in quelle delicate pergamene medievali che raccontano di una Terra sferica (anche se non ellissoide) e non già più piatta – e del resto era teoria propria a molti filosofi della Grecia antica.
Ecco quindi che, come fecero proprio i membri del Gruppo 63 vogliamo dare il nostro contributo critico e feroce: basta elenchi! E basta con i libri che utilizzano una serie di artifizi (o espedienti narrativi) ormai vetusti: basta con gli attori che sarebbero semplici attanti – incapaci di evoluzione – o con i cliffhanger (finali sospesi) tra i capitoli dei libri gialli.
E pensare che proprio il Gruppo 63 poteva vantarsi di avere al proprio interno trentenni che erano già (come scrive Eco) “con mansioni direttive” in quella che si chiamava allora industria culturale – “chi nelle case editrici, chi nei giornali, chi nella Rai”. Eppure questi brillanti intellettuali non sono riusciti, all’interno dell’establishment (sempre come rivendica Eco), a fare nemmeno un centesimo di quanto, da solo, fece Pier Paolo Pasolini (che qua fuori viveva e respirava e lottava). Al contrario. Proprio perché tanto presi a leggersi a vicenda, non scrissero che poche righe per il mondo che stava andando a rotoli al di fuori delle loro stanze (e per le generazioni seguenti).
E oggi che è ormai chiaro a tutti che con le materie umanistiche (o la Kultura, ma sì scriviamola con la K come si faceva ai tempi di Kossiga), “non si mangia” e a cinquant’anni si vivacchia con lavoretti e marchette, almeno a un povero critico – non pagato – regalate, esimi autori, un pizzico di autoironia e la capacità di togliere laddove vorreste aggiungere: perché con troppa broda (1), la minestra non migliora, perde solo di sapore.
(1) Sia nel senso di acqua dove sono stati bolliti i legumi, sia di componimento prolisso e insulso
venerdì, 28 marzo 2025
In copertina: La copertina del libro (particolare) in edizione Bompiani







