Fermare il genocidio / Dire no all’apartheid
di La Redazione di InTheNet
Il 5 dicembre si è tenuto il primo incontro organizzato da AREA – Area in Rural European* Areas (*and beyond), moderato da Anna Estdahl, al quale hanno partecipato – dai Territori Occupati e da alcuni Stati europei – artisti, esponenti del mondo della cultura e attivisti palestinesi e italiani, tra i quali Jumana Al-Yasiri, Marina Barham, Fida Touma, Shadi Zmorrod, Adham Hafez, Jihad Amro, Grazia Dentoni (1).
Durante l’incontro sono emersi diversi temi per aprire un dialogo costruttivo, tutti interessanti e sui quali bisognerà ragionare per dare continuità a questo primo momento insieme.
Le premesse storiche che hanno ‘partorito’ il 7 ottobre
Per alcuni intervenuti era, innanzi tutto, importante rettificare la narrazione dei media mainstream che hanno obliterato quanto sta accadendo nella Striscia di Gaza e nei Territori Occupati (da 75 anni e non solamente dal 7 ottobre di quest’anno) per fornire unicamente la versione israeliana, ossia la lettura unidirezionale corrente che vuole Israele impegnata non in un genocidio (con migliaia di vittime civili, tra cui bambini) bensì in un’operazione ‘chirurgica’ contro Hamas. Nonostante i 70 giornalisti uccisi nei bombardamenti israeliani su Gaza, la stampa internazionale sembra rifiutarsi di ammettere che ciò che si sta compiendo in queste settimane – di fronte a una comunità internazionale cieca, sorda e muta – è un crimine contro l’umanità e che, oltre all’autodeterminazione e all’esistenza del popolo palestinese, si stanno affossando la libertà di stampa, di critica e di parola.
Durante l’incontro si è ribadito che la situazione palestinese è degenerata negli anni. Il Territorio, sottoposto a Mandato britannico (ovvero possesso coloniale di uno Stato europeo), avrebbe dovuto essere restituito alle popolazioni che lo avevano abitato negli ultimi duemila anni ma per ragioni che non stiamo a ripetere (dalla vergogna europea per l’immane tragedia dell’Olocausto alla volontà di mantenere una entità europea all’interno del mondo arabo), l’Onu propose – sulla base dell’indagine portata avanti dall’UNISCOP (United Nations Special Committee on Palestine) – la divisione della Palestina in due Stati. Agli ebrei, nonostante fossero la minoranza, sarebbe stato assegnato circa il 55% del territorio e agli arabi (la maggioranza) solamente il restante 45%. L’idea di uno Stato laico e democratico che raggruppasse tutte le popolazioni presenti in quel momento in Palestina fu abbandonata per diverse ragioni, tra le quali la volontà degli occidentali e dei futuri israeliani di consentire massicce immigrazioni di ebrei dall’Europa devastata dalla guerra e dall’odio antisemita. A pagarne il prezzo furono, fin da quella prima proposta Onu, i palestinesi.
Durante l’incontro si è poi raccontato della Nakba (ossia la ‘catastrofe’), il primo grande esodo palestinese che costrinse oltre 700mila persone a fuggire dalle proprie case e villaggi a causa delle violenze degli israeliani e i cui discendenti non possono tornare nelle loro città d’origine a causa dell’opposizione di Israele. Nel 2015 i rifugiati palestinesi e i loro discendenti, secondo l’UNRWA (The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East) erano oltre 5 milioni, distribuiti in vari Paesi soprattutto arabi e molti nei campi-profughi interni alla stessa Palestina.
Nel tempo quanto era prevedibile si è avverato. Mentre Israele – sostenuta dall’alleato statunitense – continuava ad allargare i propri possedimenti grazie a una politica neo-colonialista, che ha permesso a oltre 800mila israeliani di stabilirsi in cittadelle fortificate all’interno delle aree ufficialmente palestinesi, ignorando (senza incorrere in sanzioni) tutte le successive Risoluzioni Onu tese a riportare i confini tra i due Stati come stabilito nel 1948; i palestinesi, in una situazione che potremmo definire di ‘cattività’, si sono visti ‘disumanizzare’ agli occhi degli israeliani. Non è necessario aver letto Erving Goffman e il suo Asylums, per capire come i palestinesi, rinchiusi in ghetti (spesso soprannominati dagli attivisti Bantustan, ossia la riproposizione delle ‘riserve’ dove erano confinati i neri sudafricani dalle autorità bianche), controllati da Israele via terra, mare, aria e per ogni necessità, si siano progressivamente trasformati, perdendo la loro dimensione umana (che è conferita più dalla dignità che non dalla nascita). Anche Gideon Levy, giornalista e attivista di sinistra – israeliano ed ebreo – ha fatto la medesima affermazione recentemente, durante un’intervista, ossia che gli israeliani non provano empatia per le sofferenze dei palestinesi perché non li considerano ‘umani come loro’.
L’ultimo tassello della ricostruzione è stato una denuncia contro la comunità internazionale e gli Stati Uniti, in primis, che nulla hanno fatto per ristabilire il diritto internazionale dal 1967 a oggi, e che non stanno imponendo sanzioni né smettendo di commerciare o inviare armi a Israele. Il genocidio a Gaza potrà continuare impunemente e sarà completato dall’espulsione dei palestinesi anche dalla Cisgiordania, se la comunità internazionale non agirà imponendo a Israele il rispetto delle Risoluzioni Onu – anche con strumenti come il boicottaggio dei suoi prodotti, le sanzioni e, ovviamente, smettendo di fornire armi.
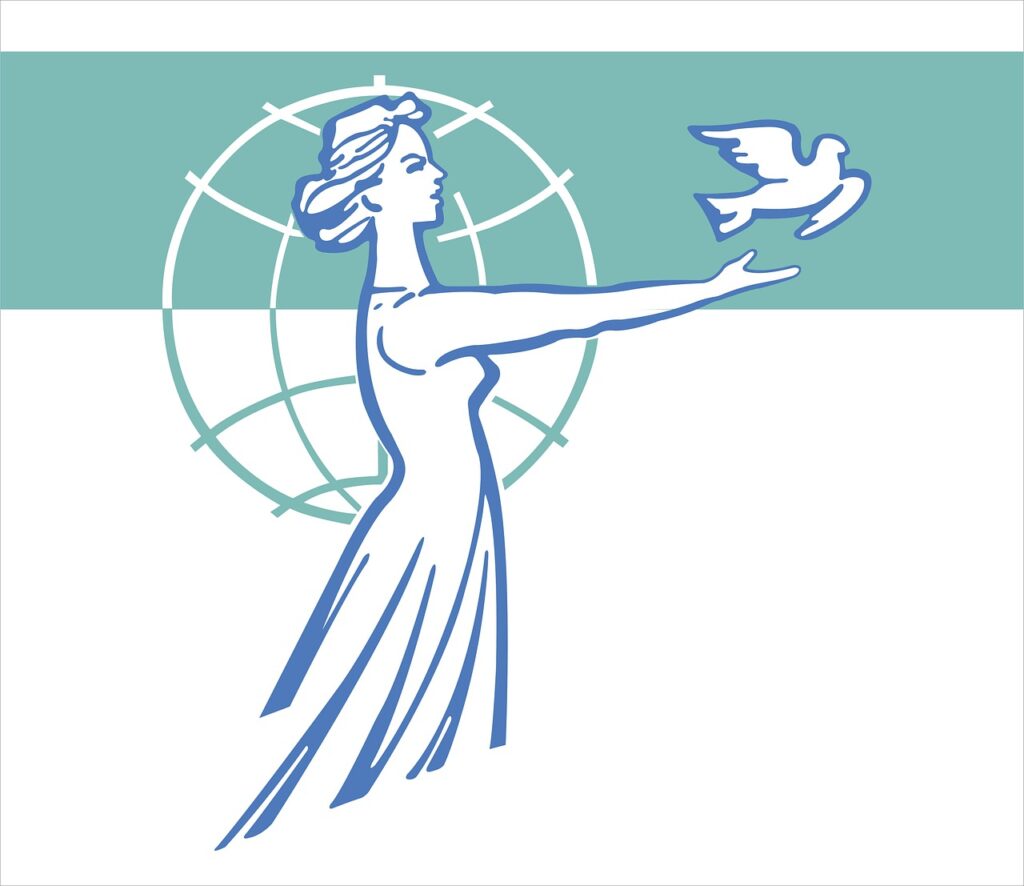
Palestine unite
“How good and how pleasant it would be / Before God and man, yeah / To see the unification of all Africans, yeah”, cantava Bob Marley e sicuramente durante l’incontro è emersa sia la volontà del popolo palestinese di agire superando le divisioni politiche interne, sia la profonda sfiducia nelle istituzioni internazionali e soprattutto nell’Europa. Il doppio standard, che la Russia ha denunciato fin dall’inizio dell’Operazione Speciale in Donbass, è ormai sotto gli occhi di tutti. Ancora una volta, non è necessario aver letto Noam Chomsky per capire come coloro che l’Occidente considera alleati politici o geo-strategici possano permettersi di commettere persino crimini di guerra, impunemente, con il silenzio/assenso delle cosiddette democrazie occidentali (detentrici e portatrici dei valori cosiddetti universali).
Lo scoramento espresso da alcuni di fronte alla vastità della distruzione, alla crudeltà delle azioni e alla disumanità nei confronti dei bambini di Gaza, da parte dell’esercito israeliano, è profondo. Molti hanno detto di sentirsi impotenti e hanno denunciato come, anche vivendo in Europa, si sentano ‘minacciati’ in quanto può bastare una parola o qualche forma di critica a quanto sta accadendo per vedersi accusati di antisemitismo ed essere costretti al silenzio. Ma in tutti è forte il desiderio di lottare con mezzi pacifici, politici e con le arti, la cultura e il dialogo, nelle università e nelle piazze (anche virtuali), per modificare la narrazione imperante e aprire gli occhi alla società civile di fronte a due fatti inconfutabili: i palestinesi sono essere umani e come tali hanno pari dignità degli israeliani e, secondo, occorre garantire loro non solamente la sopravvivenza ma una vita da uomini e donne libere, e la possibilità di autodeterminarsi come popolo.
La questione che deve essere riesaminata e contestualizzata – anche storicamente – è quanto successo il 7 ottobre. Quel deprecabile singolo fatto di sangue, che ha portato alla morte forse di 1.400 israeliani (ma le stime sono provvisorie dato che si sta scoprendo che molti israeliani sarebbero stati uccisi dal loro stesso esercito, 2) è stato ampiamente superato in ferocia dal massacro di 16mila palestinesi – cifra raggiunta il 5 dicembre, proprio nelle ore in cui si sta tenendo questo incontro. Si è andati ben oltre l’efferatezza dei nazi-fascisti che pretesero dieci italiani ogni tedesco ucciso – ed è inutile onorare le vittime delle Fosse Ardeatine, se si permette poi la rappresaglia degli israeliani contro i civili e i bambini a Gaza.
La solidarietà dei giovani verso la Palestina nasce sui social
Nell’incontro è emerso un dato che fa ben sperare: pare che i giovani (meno condizionati dai media mainstream e dalla narrazione del potere filo-israeliano) abbiano iniziato a usare i tanto demonizzati social per scambiarsi informazioni, pensieri, idee e condividere iniziative in sostegno della popolazione di Gaza. Come abbiamo denunciato più volte da queste pagine, forse è proprio perché la rete resta uno degli ultimi baluardi della contro-informazione e della libertà di espressione che i tentativi dei Governi è di stringere le maglie della censura (3, 4). Tra fact-checkers che paiono investiti di un sapere messianico che li rende in grado di tutto giudicare e decidere, le propagandistiche e bombastiche Pillole contro la disinformazione, e una Commissione europea che è talmente ‘democratica’ da non rendere pubblici gli accordi con Pfizer ma tiene talmente alla nostra ‘educazione alla cittadinanza’ da pretendere che i social si trasformino in mastini da guardia o, peggio, in emissari di un GF che spia le nostre opinioni per cancellarli dalla narrazione e persino dallo scambio con amici e parenti, è ovvio che proprio a mezzo di una piattaforma condivisa si possono comunicare idee, iniziative, informazioni ed esperienze che abbiano più fini – dal far circolare idee a valorizzare azioni creative.
L’azione artistica è stata più volte richiamata come indispensabile per far uscire il popolo palestinese dal silenzio e dalla dimensione non umana nella quale vorrebbe costringerlo il potere israeliano. Ma anche la contro-informazione che arrivi a sensibilizzare le persone su quanto sta accadendo, andando oltre le notizie asettiche dei Tg o la propaganda può essere utile. Mostrare, condividere, analizzare, criticare, diffondere. E poi avviare campagne di boicottaggio, di pressione sui Governi perché si dissocino dai crimini israeliani sospendendo i rapporti diplomatici e commerciali che significano, nella pratica, essere complici dell’immane distruzione di Gaza. E ancora, chiedere a gran voce le sanzioni (non unilaterali ma proclamate dall’Onu) e ricordarsi come solamente quando la comunità internazionale ha cominciato a opporsi alla Guerra statunitense in Vietnam o all’Apartheid in Sudafrica sia iniziato a scricchiolare il sistema di potere che aveva sorretto l’invasione Usa e il regime razzista. Anche rifiutarsi di collaborare con le istituzioni che non ammettono ciò che sta accadendo realmente in Palestina e che non credono che il diritto del popolo palestinese alla vita e all’autodeterminazione sia imprescindibile dovrebbe essere una forma di pressione – che ognuno di noi può e deve portare avanti anche nella quotidianità.
L’idea di creare questa piattaforma condivisa è, quindi, una tra le proposte principe che è emersa alla fine dell’incontro – e che AREA valuterà come fare propria.
Serviranno tempo, impegno ed energie. Ma la redazione di InTheNet continuerà a impegnarsi attivamente e pubblicamente credendo fermamente in quella disobbedienza civile e non-cooperazione non-violenta che ha portato l’India del Mahatma Ghandi a liberarsi dal colonialismo britannico.
(1) le esperienze lavorative degli intervenuti all’incontro e i loro siti per conoscerli meglio: https://www.inthenet.eu/2023/12/01/incontro-internazionale-con-artisti-e-attivisti-palestinesi/
(2) uno tra i molti articoli che stanno comparendo sulla stampa: https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-cosa__successo_il_7_ottobre_soldato_israeliano_rivela_lordine_di_sparare_indiscriminatamente_contro_un_kibbutz/39602_51825/
(3) si veda cos’è NewsGuard: https://www.inthenet.eu/2023/02/10/newsguard/
(4) le nuove ‘forche caudine’ europee: https://www.inthenet.eu/2023/09/22/la-censura-come-forma-di-liberta/
venerdì, 8 dicembre 2023
In copertina: Foto di PixelAnarchy da Pixabay; nel pezzo: Foto di Агзам Гайсин da Pixabay







