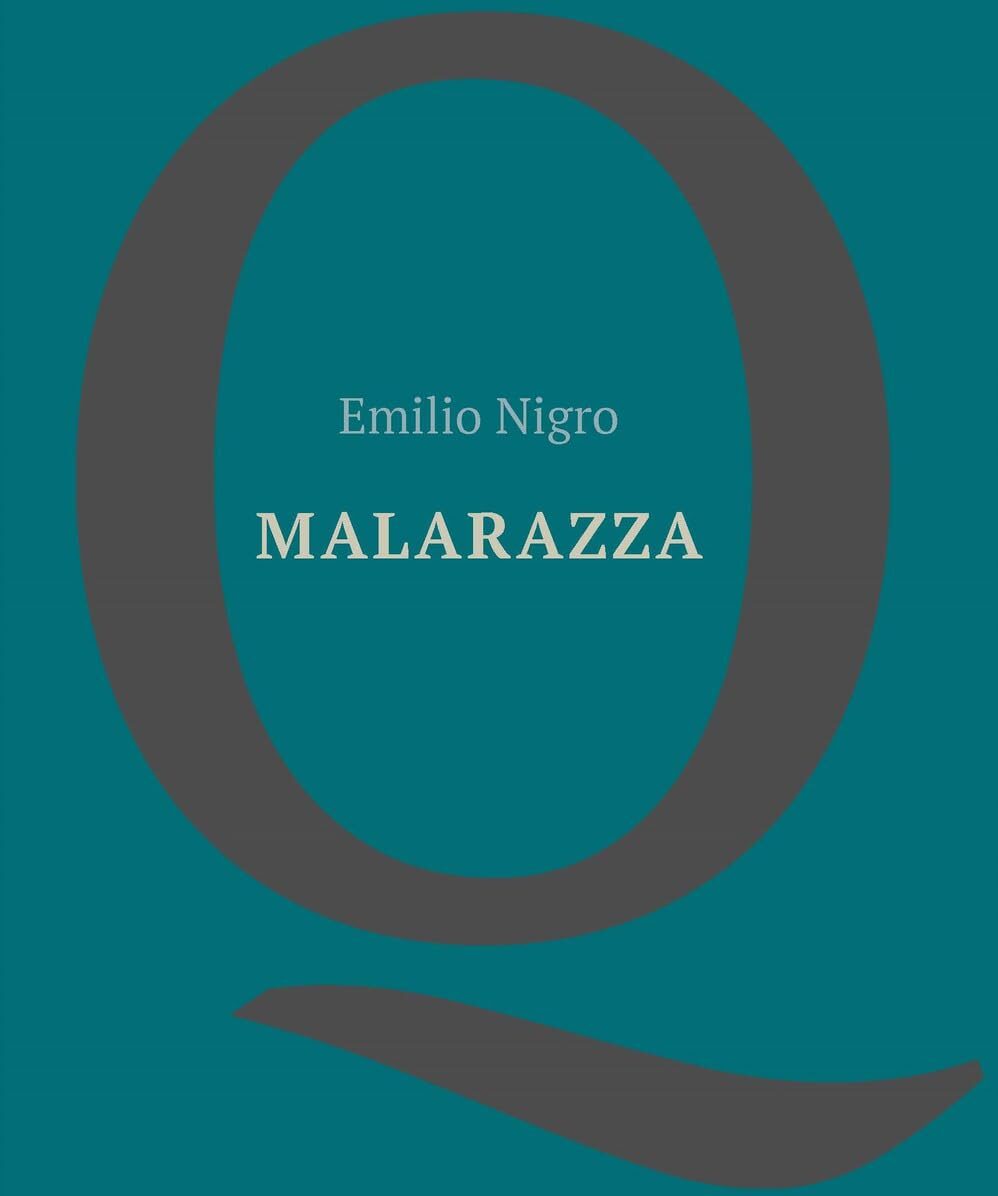
Esce, per Qed Edizioni, una raccolta di racconti di Emilio Nigro
di Simona Maria Frigerio
Emilio è un collega critico che conosco da anni e, a volte, collabora con la nostra redazione di InTheNet. Giocando sempre a carte scoperte coi nostri lettori non fingerò, quindi, di non aver condiviso delle cene in quel di San Gimignano a Orizzonti Verticali, Festival ideato e diretto da Tuccio Guicciardini e Patrizia De Bari. Ma gli anni sono passati, le vite hanno prese strade che ci hanno allontanati ma è rimasta, di quell’amicizia, il rispetto reciproco per il lavoro l’uno dell’altro. E il rispetto, oggi, è qualcosa di raro: vuoi perché in troppi deludono le nostre attese (forse eccessivamente alte), e vuoi perché troppi altri si svendono per un piatto di fagioli e il parterre critico e letterario italiano è ormai uno sgomitare di pseudo-universitari che credono di capire le arti solo perché hanno seguito qualche corso d’una manciata d’ore, tenuto da qualche anima fallita – che si dà arie di critico perché non trova come altrimenti campare: chi gli pagherebbe sennò una cena o un viaggio?
Tanto spleen baudelairiano mi viene forse dal titolo del piccolo volume, denso, che Emilio mi ha inviato per leggerlo e, se me la sentivo, recensirlo – Malarazza. Chi oggi più dell’intellettuale, che si merita sì ormai l’appellativo vetusto e di trista memoria, di ‘culturame’, si meriterebbe di essere considerato malarazza?
E invece Nigro, lo scrittore, dedica quell’appellativo a un marchesino, ad esempio, che nel primo racconto tradisce l’amico d’infanzia quando si rende conto del divario sociale che li separerà per sempre, lui di nobili origini – che, in meridione, dopo la cosiddetta Unità d’Italia, si sono identificate spesso con un latifondismo parassitario – e l’altro, umile, come potrebbe esserlo il figlio di un contadino, magari dei tempi fascisti, quando i braccianti pagavano con il confino al nord le lotte agrarie (come capitò ai fratelli di mio nonno). Si sente il respiro caldo come la terra arsa di Calabria (da dove entrambi proveniamo) già in questo primo capitolo, in cui la costruzione delle frasi così come la scelta dell’aggettivo o la creazione di un neologismo a cavallo tra dialetto e poesia, riporta alla mente altri modi di scrivere, più prossimi al sangue natio. Ovvero, meno artificialmente omologa(n)ti di quei Premi Strega (ricordiamo che già nel lontano 2009 si dimise perfino Andrea De Carlo dalla giuria, denunciando le manipolazioni dei grandi gruppi editoriali), che paiono scritti tutti con la stessa mano (o, ormai, con la medesima ‘intelligenza’ artificiale). Ma si sa che se un popolo pende dalle labbra dei protagonisti di Un posto al sole, immedesimandosi in vicende talmente stantie (che persino gli interpreti faticano a crederci), non si può pretendere che la letteratura percorra binari altri, che si allontani dalla medietà già nota e rassicurante, da una lingua che è quell’italiano sub-standard che va bene sia per il reality sia per il pomeriggio televisivo, quando ci insegnano a lavarci le ‘manine’.
Malarazza è però anche parlar fuor di denti. Chiedersi cosa è vita e cosa non lo è. Osare rifiutare la morte asettica in un ospedale, l’estremo atto di ribellione che ci viene negato da una medicina che centellina la sofferenza fino a farcela ingurgitare come misericordia. Allungarci la sofferenza, ecco a cosa servono ormai – sempre più spesso – le cosiddette cure. E se qualcuno si rifiuta è la morale, il senso di colpa degli altri, oppure le apparenze, il decoro della famiglia, la pia falsità dei benpensanti baciapile, a impedirci di dire ‘basta’, a costringerci rinchiusi in un corpo che non ci appartiene oltre, in una mente che ci sfugge dalle dita e muore prima di arrivare alle labbra. Come nelle Invasioni barbariche, però, la risposta dovrebbe essere quella che dà Nathalie a Remy quando confessa: «Ho avuto troppo dalla vita: il vino, i viaggi, i libri, le donne. Forse è per questo che mi dispiace lasciarla!». E lei, infermiera/officiante laica della sua redenzione, risponde: «Forse non è questa la vita che le dispiace abbandonare, ma quella che ha avuto un tempo!». Qualità, dignità, rispetto, quelli che un braccio, nel secondo racconto di Emilio Nigro, riafferma come prioritari su un respiro che è ormai fine a se stesso – un alito di morte, invece che di vita.
Ma non vogliamo togliervi il gusto di leggere questo piccolo libro denso che spazia tra passato e presente prossimo raccontandovi ogni trama. Sarebbe imperdonabile. Perché il volume va letto, in privato e in silenzio, meglio soli che male accompagnati… Però un’ultima chicca ve la vogliamo lasciare. Come il sapore dei cuddurieddi che preparava mia nonna per antipasto, così da aprirvi lo stomaco e la mente e farvi venir voglia di proseguire voi, con la lettura. Perché una buona lettura è come una buona cena: si ricorda e si riassapora anche dopo mesi, o anni – e non occorre aver assaggiato una Madeleine per saperlo.
L’ultimo racconto ha il sapore della fiaba. Già dal titolo lo si comprende: Mangiafuoco e Morsitinto. Il primo burattinaio (quasi ovviamente), il secondo pittore. Ma soprattutto, entrambi, simboli di un fare teatro che è logica mercantilistica o necessità creativa. Come nell’Animal Farm di George Orwell, però, il cerchio umano o dis-umano si chiude sempre e, tra l’ignavia e l’indifferenza, qualsiasi atto, anche il più atroce, può compiersi perché «Se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi». I riferimenti in questa favola sono molteplici, colti o personali, come le metafore che si affastellano all’orizzonte di una scrittura che diventa bambina – nel senso che questa fiaba potrebbe essere letta anche a un bambino, così come a un erudito – che vi scorgerebbe l’arrivo di Hernan Cortés da Moctezuma II. Come una cipolla è il teatro, quando è buon teatro, perché è a strati e ognuno ne gusta un velo, disvelando ad altri occhi, il cuore. Così è un racconto quando è un buon racconto, a strati, e ognuno – a seconda della propria cultura, delle letture fatte, o anche delle proprie esperienze di vita – può trovarci un pezzo di sé. Ma da critico e conoscendo Emilio io vi leggo un J’accuse al pari di quello di Zola, quando egli scrive: “i cittadini non si incontrarono più a teatro per comunicare tra loro e riconoscere (e determinare) il loro destino nella parola comune e nelle scene, fruivano del teatro da spettatori, da consumatori”. Come mi disse un giorno Dario Marconcini, regista e attore stimabile che si ‘faceva la voce’ gridando «Hồ Chí Minh!» sulla spiaggia di San Rossore, nei lontani anni 70: «Uscimmo dai teatri e incontrammo finalmente gli spettatori, poi vi rientrammo e fummo risucchiati dalle istituzioni».
Lo stoico Lucio Anneo Seneca pare che disse: “Fa una scelta di buoni autori e contentati di essi per nutrirti del loro genio se vuoi ricavarne insegnamenti che ti rimangano. Voler essere dappertutto è come essere in nessun luogo. Non potendo quindi leggere tutti i libri che puoi avere, contentati di avere quelli che puoi leggere”.
venerdì, 25 ottobre 2024
In copertina: La copertina del libro (particolare per ragioni di layout)







