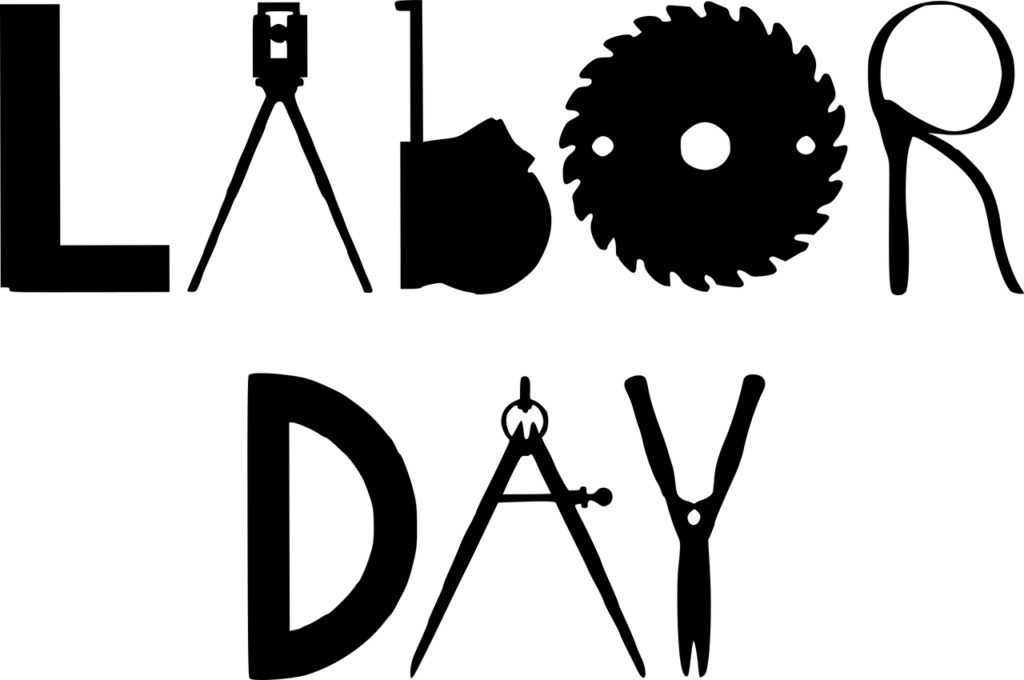
Il pragmatismo svedese forse ci avrebbe resi vincenti
di Simona Maria Frigerio e Luciano Uggè
Quest’anno, più che mai, c’è ben poco da festeggiare e occorre fare il punto sulla situazione economica e lavorativa in un Paese, come l’Italia, dove la disoccupazione – soprattutto tra i giovani e le donne – resta un problema endemico contro il quale nessun ‘vaccino’ pare funzionare.
Gli ultimi dati Istat (ancora provvisori) inquadrano una situazione preoccupante. Riassumendo, a febbraio, il tasso di occupazione era pari al 56,5% mentre il tasso di inattività è stabile al 37% (ossia, una persona su due non lavora). “Il livello dell’occupazione nel trimestre dicembre 2020-febbraio 2021 è inferiore dell’1,2% rispetto a quello del trimestre precedente (settembre-novembre 2020), con un calo di 277 mila unità” e , sempre a livello trimestrale “aumentano sia le persone in cerca di occupazione (+1,0%, pari a +25 mila), sia gli inattivi tra i 15 e i 64 anni (+1,3%, pari a +183 mila unità)”. È lo stesso Istat ad affermare, nero su bianco, che “Le ripetute flessioni congiunturali dell’occupazione – registrate dall’inizio dell’emergenza sanitaria fino a gennaio 2021 – hanno determinato un crollo dell’occupazione rispetto a febbraio 2020 (-4,1% pari a -945 mila unità). La diminuzione coinvolge uomini e donne, dipendenti (-590 mila) e autonomi (- 355 mila) e tutte le classi d’età. Il tasso di occupazione scende, in un anno, di 2,2 punti percentuali” e chiude: “Nell’arco dei dodici mesi, crescono le persone in cerca di lavoro (+0,9%, pari a +21 mila unità), ma soprattutto gli inattivi tra i 15 e i 64 anni (+5,4%, pari a +717 mila)”.
Ma qual è la differenza tra occupati, disoccupati e inattivi? Parrebbe logico supporre che i primi siano quelli che hanno un lavoro contrattualizzato, i secondi quelli che lo cercano, ma sui terzi sorgono i primi dubbi. In realtà, la situazione è più complessa per tutte e tre le categorie e molto meno rassicurante – per non dire che il primo dato si potrebbe considerare gonfiato e se un occupato su due sembrava già poco, pensare che siano anche meno è davvero allarmante.
In effetti, secondo la definizione dell’International Labour Organization, adottata dai vari istituti statistici presenti nei diversi Paesi (compreso l’Istat), si considera occupato chiunque abbia compiuto 15 anni (e fino a 89) e abbia svolto almeno un’ora di attività retribuita (o non retribuita se nella ditta familiare) nella settimana precedente. Vi è anche un limite di 3 mesi di sospensione dal lavoro, con o senza compenso, per stabilire se si è occupati (sì, ad esempio, se in maternità, no se cassintegrati). A questo punto si capisce che anche lavoratori saltuari, con un monte ore mensile irrisorio e senza alcuna garanzia di continuità e stabilità possano essere considerati occupati. Un’ora a settimana, ossia quattro al mese, ci fanno rientrare d’ufficio tra gli occupati!
I disoccupati, invece, sono coloro che hanno effettuato almeno “un’azione attiva di ricerca di lavoro nelle quattro settimane precedenti” e siano “disponibili a lavorare (o avviare un’attività autonoma) entro le due settimane successive” (https://www.ingenere.it/articoli/occupati-disoccupati-inattivi). Di fronte a tale spiegazione ci si domanda, quindi, se una persona che abbia lavorato – magari in prova – per quattro ore in un mese e inviato 10 curricula o risposto a un annuncio di offerte d’impiego, rientri nella prima o nella seconda categoria.
Gli inattivi, infine, sarebbero coloro che non hanno prestato nemmeno un’ora di lavoro né inviato un curriculum o risposto a un annuncio, sostenuto un colloquio o si siano sognati di aprire una qualche attività – o, più semplicemente, non si siano iscritti ai Centri per l’impiego ben sapendo che tale azione ha un effetto quasi nullo sull’occupazione in Italia (secondo varie fonti giornalistiche coloro che trovano un posto seguendo questo canale sarebbero tra l’1,8 e il 2,5%).
Aumentano anche la povertà relativa e quella assoluta
Il presidente dell’Ordine degli Assistenti Sociali, Gianmario Gazzi, il 4 marzo scorso ha commentato i dati resi pubblici dall’Istat, affermando che ci sono: “2 milioni di famiglie in povertà assoluta e si torna al 2005, con un pauroso passo indietro rispetto al 2019” e più oltre, rispetto al futuro, ha invitato a: “percorrere strade diverse dai bonus a pioggia e incontrollati e a programmare per l’oggi e il futuro i servizi utili a chi non ha nulla. Perché né per ieri, né per il domani prossimo venturo, sarà possibile abolire la povertà”.
Il raddoppio del numero delle famiglie in stato di povertà assoluta cosa significa? Ebbene, che 5,5 milioni di persone (quasi il 10% della popolazione italiana) non ha di che sfamarsi o mezzi per rispondere ad altri bisogni primari (quali sanità, istruzione, esigenze abitative). Il dato è in crescita maggiormente al nord e ciò che colpisce è che interessi non solamente le famiglie numerose ma soprattutto i lavoratori tra i 35 e i 44 anni – ossia appartenenti a quella fascia d’età che dovrebbe essere economicamente più stabile e garantita – che dovrebbero essere l’ossatura di una società sana.
Se i tassi di povertà assoluta ci riportano al 2005, la spesa media familiare crolla ai livelli del 2000: si passa da 2.560 euro mensili del 2019 a 2.328 euro mensili (un -9,1% che rimanda all’altrettanto rilevante diminuzione del Pil). Secondo Demoskopika, a livello di sistemi economici, le regioni del nord appaiono le più colpite – con il Piemonte in ‘maglia nera’ soprattutto a causa dei prestiti alle imprese che sono aumentati, nel 2020, di oltre 9 miliardi di euro (+19% rispetto al 2019); mentre il Veneto deve fare i conti con 56 mila famiglie in più che denunciano un forte disagio economico. E la Liguria tocca un -21,2% di nuove aziende.
Imprese sull’orlo di una crisi di nervi
Edilizia, turismo e ristorazione sono i settori aziendali maggiormente a rischio secondo l’analisi del Cerved – che, tra l’altro, non si discosta di molto dalla comune impressione dei cittadini. Sul filo del rasoio starebbero 115 mila imprese, soprattutto medio-piccole e del centro-sud (dove il lavoro, come ben sappiamo, era già un’ardua conquista prima del Covid-19).
Sebbene il settore manifatturiero sia stato ritenuto essenziale e, quindi, sia stato quello maggiormente preservato dai lockdown – a scapito di istruzione, cultura, commercio, sport e terziario – andrebbe considerato che aver privilegiato, ad esempio, chi costruisce autovetture (a fronte di consumi ridotti sia a causa dell’impoverimento e dell’incertezza economica delle famiglie, sia della mancanza di vita sociale, spostamenti e viaggi), significa non aver tenuto in considerazione che l’Istat, nel 2019 (dati del 2018), fotografava tutt’altra situazione. Ossia, una crescente terziarizzazione delle attività e, di conseguenza, di tale settore quale fonte di lavoro, ricchezza e tassazione. In effetti – tra il 2011 e il 2018 – le imprese del terziario sono passate dal 65,6 al 70,3%, mentre i lavoratori hanno toccato quota 64% pari a un incremento del 5%. Ma si vede che i vari Governi succedutisi negli ultimi anni (sostenuti, in questo, dai sindacati) non se n’erano accorti, e pensavano che i lavoratori italiani fossero ancora, in gran parte, le tute blu degli anni 70.
Deficit/Pil: voragini da colmare per la next generation
Mentre abbiamo un nuovo scostamento di bilancio da 40 miliardi di euro (ossia un raddoppio della manovra economica prevista per il 2021), il rapporto deficit/Pil italiano vola ai livelli del 1991, ossia all’11,8% (ipotizzando, tra l’altro, una alquanto improbabile crescita del Prodotto Interno Lordo al 4,5%). Se si pensa che il disavanzo pubblico non dovrebbe superare il 3% ci si renderà conto di quanto sia grave la situazione. Come scrive Wallstreetitalia.com, “il governo prevede che, dopo il recupero del 4,5% nel 2021, il Pil italiano potrà salire del 4,8% nel 2022, del 2,6% nel 2023 e dell’1,8% nel 2024. Ovvero ‘tassi di incremento mai sperimentati nell’ultimo decennio’, sottolineano da Palazzo Chigi”. La frase suscita più di un dubbio. In primis perché, se il recupero è rispetto al 2020, significa poco o nulla visti i risultati pessimi dell’anno passato; in secondo luogo, non si capisce come la politica italiana pensi seriamente che la nostra economia possa fare tali exploit in un periodo di difficile ripresa (almeno per l’Europa e gli Stati uniti), quando negli anni ‘buoni’ risicava incremento del Pil ridicoli. Non ci credete? Facciamo un semplice confronto.
Al 31 dicembre del 2019 “il debito delle Amministrazioni pubbliche era pari a 2.409,2 miliardi; a fine 2018 il debito ammontava a 2.380,6 miliardi” – come da dati ufficiali. In un anno sostanzialmente positivo come il 2019, l’Istat stimava una crescita del Pil solo dello 0,2%, mentre prevedeva uno 0,6% nel 2020.
Nel 2020, al contrario, il Pil diminuisce dell’8,9% – il calo peggiore da vent’anni a questa parte. Il debito pubblico, invece, a fine 2020 raggiunge i 2.569,3 miliardi, ovvero aumenta di quasi 160 miliardi di euro (+5,4%). Mentre il rapporto debito/Pil sale dal 134,6% del 2019 al 155,6% del 2020.
Se si pensa che il Next Generation EU dovrebbe assicurarci (spalmati però su più anni) circa 209 miliardi di euro (di cui 128 saranno prestiti, di cui la prossima generazione si farà carico per trent’anni a livello di capitale e interessi), si comprende che con un tale deficit stiamo ancora una volta prendendo ‘lucciole per lanterne’. E adesso vediamo se riuscite a essere altrettanto ottimisti dei nostri politici.
La perdita di lavoro e imprese significa un minor gettito fiscale
Meno tasse più felici? No, quando ci si accorge che significa meno servizi per tutti i cittadini: meno trasporti, meno sanità, meno istruzione, pensioni e stipendi della pubblica amministrazione a rischio.
Le entrate tributarie, com’era facile prevedere, sono anch’esse diminuite. E del resto pensare che un’impresa sia essenziale in base a un calcolo operaistico e non al fatto che ciascuna impresa, in un sistema capitalistico, è un anello di una catena indispensabile al funzionamento dell’intera macchina, è davvero miope. Credere che non avrebbero inciso sulla collettività – in quanto servizi non essenziali – le chiusure di hotel e ristoranti, discoteche e teatri (che, comunque, hanno continuato a essere interamente finanziati, a differenza dei bonus ridicoli ricevuti dalla ristorazione o dalle partite Iva), agenzie viaggi e negozi, aeroporti e università (con i minor introiti degli studenti fuori sede per l’intero indotto), palestre e impianti sciistici, eccetera, significa ragionare come se si fosse seduti al bar e non in un Parlamento. Come dichiarare che si riapre mantenendo il coprifuoco alle 22.00, equivale a dire che non si riapre: chi potrà mai andare a teatro, al cinema o a un ristorante se deve rientrare a casa prima che l’ora scocchi e la carrozza si ritrasformi in zucca?
Come riporta informazionefiscale.it, i dati del “Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 15 marzo 2021, registrano un calo complessivo di gettito del 6,4% rispetto al 2019 (46 miliardi) e una diminuzione del 5,8% a gennaio 2021 rispetto all’anno precedente (3 miliardi)”. 46 miliardi sono una cifra pari a un’intera Legge di Bilancio, a un’intera manovra economica, a oltre un terzo del prestito del Next Generation EU.
Forse gli svedesi hanno avuto sempre ragione?
Venerdì, 30 aprile 2021
In copertina: Foto di Mohamed Hassan da Pixabay.







