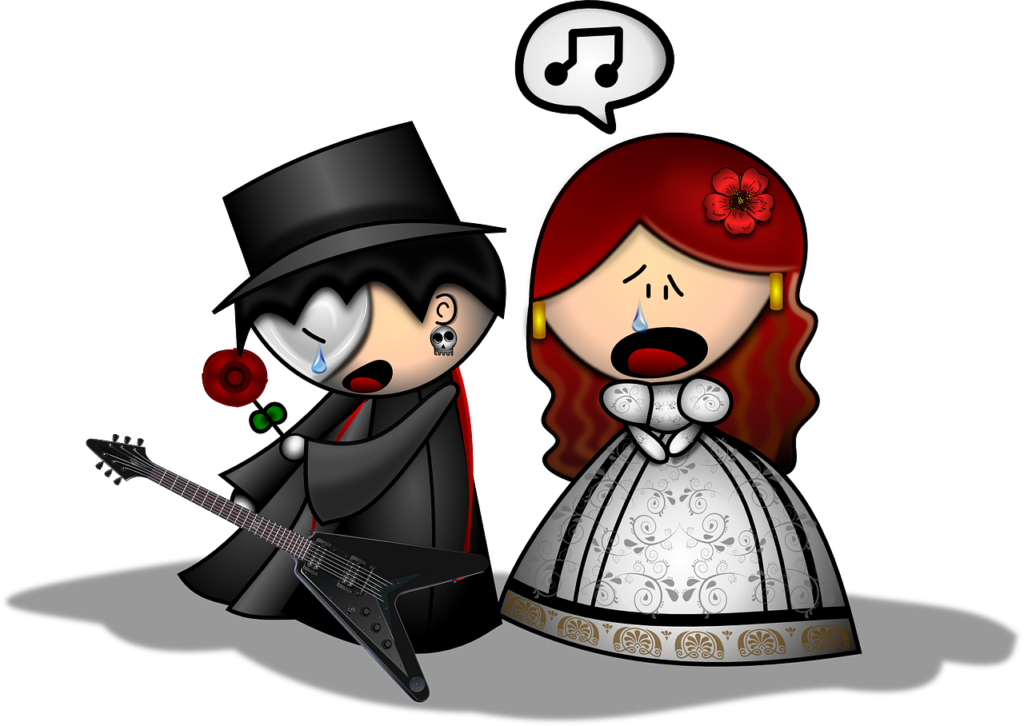
Saremo bellissimi e giovanissimi sempre?
di Simona Maria Frigerio
Ancora prima del lockdown, la politica italiana (ma non solo) ha deciso che si potesse fare a meno della cultura. Gli italiani potevano ancora sedere al bar per l’aperitivo o andare al ristorante, ma non pascere gli occhi in un museo, applaudire a uno spettacolo teatrale, godersi un film sul grande schermo. Potevano, in pratica, dimenticare i propri dolori su un cocktail dal nome esotico, ma non confrontarsi con il senso della tragedia umana sulle assi di un palcoscenico o riflettere sulla fine del sogno liberista – denunciata con ferocia e perfetto effetto sincronico, propriamente artistico, in Joker o Parasite.
Scelta, questa, indicativa di un sistema di pensiero e di potere. Imposta ma anche subita supinamente da chi forse avrebbe dovuto avere la forza e la lungimiranza di vedere il pericolo insito in questo schiaffo alla cultura, ma anche all’educazione (con la beffa della scuola online), e alle forme di socializzazione attiva (ossia critica) di fronte a quelle di socializzazione passiva – un drink o una pizzata con gli amici, altrettanto legittime ma certamente meno scomode e urticanti, nel momento in cui si vogliano o si debbano restringere le libertà civili.
La resa incondizionata del teatro è stata seguita da un uso dell’online per ovviare all’impossibilità della compresenza. E dalla richiesta, di buona parte della critica, a Mamma Rai di fare cultura come ai tempi del bianco e nero, quando l’alfabetizzazione, prima, e l’appropriarsi di una lingua unificante, ma altresì omologante, poi, passavano dalla Telescuola e da Non è mai troppo tardi – oltre che dal servizio di leva. Esistono però anche seri pericoli in questa deriva virtuale e televisiva e forse sarebbe il caso, proprio in tempi in cui è possibile riflettere, prepararsi alle sfide incombenti.
Il primo dubbio riguarda proprio la televisione di Stato. Non tanto perché si voglia fare una critica alle scelte fin qui operate e che dimostrano, in campo teatrale e artistico, una certa resistenza a qualsivoglia spettacolo di ricerca e contemporaneo, oltre a una preferenza per il botteghino, i nomi noti e una tradizione stantia e datata – salvo rare eccezioni come Skianto di e con Filippo Timi, o Elena dal Teatro Greco di Siracusa per la regia di Davide Livermore. Bensì perché, anche se Mamma Rai facesse uno sforzo prometeico, non potrebbe che supplire con un numero ovviamente ridotto di proposte, privandoci comunque del rito laico del teatro – che è anche vestirsi, uscire di casa, incontrare persone, confrontarsi con le stesse su quanto si è visto e ascoltato. Ma è soprattutto scegliere. Questa, la discriminante. Altrimenti perché si rivendicherebbe che proprio il teatro dei piccoli numeri debba essere finanziato? Affidare a uno Stato e ai suoi mass media – ma si potrebbe dire altrettanto di un privato – la facoltà di scegliere cosa è cultura e, di conseguenza, cosa proporci come spettacolo teatrale, sarebbe non solamente antidemocratico, negli esiti, ma pernicioso a livello ideologico e, quindi, nelle intenzioni.
Il secondo pericolo sta non tanto in ciò che si vede, ma nella perdita della socializzazione. Il teatro, prima ancora del cinema (che chiede solo una compresenza di spettatori), obbliga alla compartecipazione di attore e spettatore. La carne e il sangue, la polvere del palcoscenico, il sudore e la pancia propri di quest’arte antica quanto la civiltà occidentale – e perciò intrinsecamente legata a ciò che siamo diventati – non sono vuoti termini superabili con nuovi mezzi. Nel teatro il medium è parte intrinseca del suo farsi e del suo porgersi all’altro da sé. Come un’opera d’arte vista su uno schermo del computer è solo piatta riproduzione. E a dimostrazione di quanto scrivo, basti vedere Arca Russa di Aleksandr Sokurov che, per quanto maestoso e affascinante, non potrà mai restituirci l’esperienza di bighellonare, infreddoliti, lungo i corridoi del Palazzo d’Inverno di Leningrado (o San Pietroburgo). Così il teatro televisivo o online è solo vaga imago della tridimensionalità di un’arte che, nel qui e ora, trova la sua giustificazione d’essere. Il teatro è irripetibile. E la catarsi (se voluta) è solamente frutto di quella compartecipazione tra attore e spettatore, e tra spettatori, che si attua nell’istante del riconoscimento – senza l’orpello di un’inquadratura, senza l’ausilio di un primo piano: la società si specchia in se stessa, nei propri miti, nelle proprie tragedie, nel proprio umanissimo dolore.
La fine dell’immanenza teatrale come metafora della fine della nostra società, quindi? Molti ventilano questa ipotesi, alcuni la dichiarano necessaria a una civiltà che voglia conservarsi, che voglia addirittura perpetuare la vita di fronte alla minaccia di un’influenza con possibili complicanze polmonari, soprattutto in persone ultrasettantenni con precedenti patologie. E uso i termini con doviziosa precisione per restituire al Covid-19 il suo biologico status di virus – togliendogli di dosso gli orpelli della retorica che gli arrogano una volontà precisa, e ne fanno un’entità senziente.
Mesi fa assistetti al Teatro Verdi di Pisa a Saremo bellissimi e giovanissimi sempre, un’interessante riflessione multidisciplinare di Marco Chenevier a partire dal pensiero di Meister Eckhart. Ecco, il modo in cui la società occidentale sta affrontando l’epidemia da coronavirus, mi pare perfettamente in linea con alcune sottotracce di quello spettacolo che, guarda caso, forse non sarebbe mai approdato sulla Rai – talmente ibrido che, difatti, fummo in pochi ad applaudirlo anche a teatro. Europei e statunitensi si stanno forse accorgendo, per la prima volta da decenni, che non possono vaccinarsi contro la morte. Nonostante i continui lifting – che ci hanno resi plasticosi come Barbie e Ken – e i nostri armadietti trasformati in farmacie ambulanti, moriamo. E moriamo perché siamo, innanzi tutto, vecchi. Com’è naturale. Come avviene molto prima in quel resto del mondo, che preme contro i nostri confini e concima i fondali del Mare Nostrum. E il qui e ora del teatro, quell’immanenza che ci rende consapevoli che solo questo momento ha valore, perché lo sto vivendo ed è irripetibile, è monito e simbolo di un’esistenza, dell’esistenza – della nostra comune, fragilità mortale. Ecco perché il teatro deve esserci in presenza. Perché no, non saremo bellissimi e giovanissimi sempre – ed è ora di accettarlo.
2 aprile 2020
In copertina: Foto di OpenClipart-Vectors da Pixabay.







